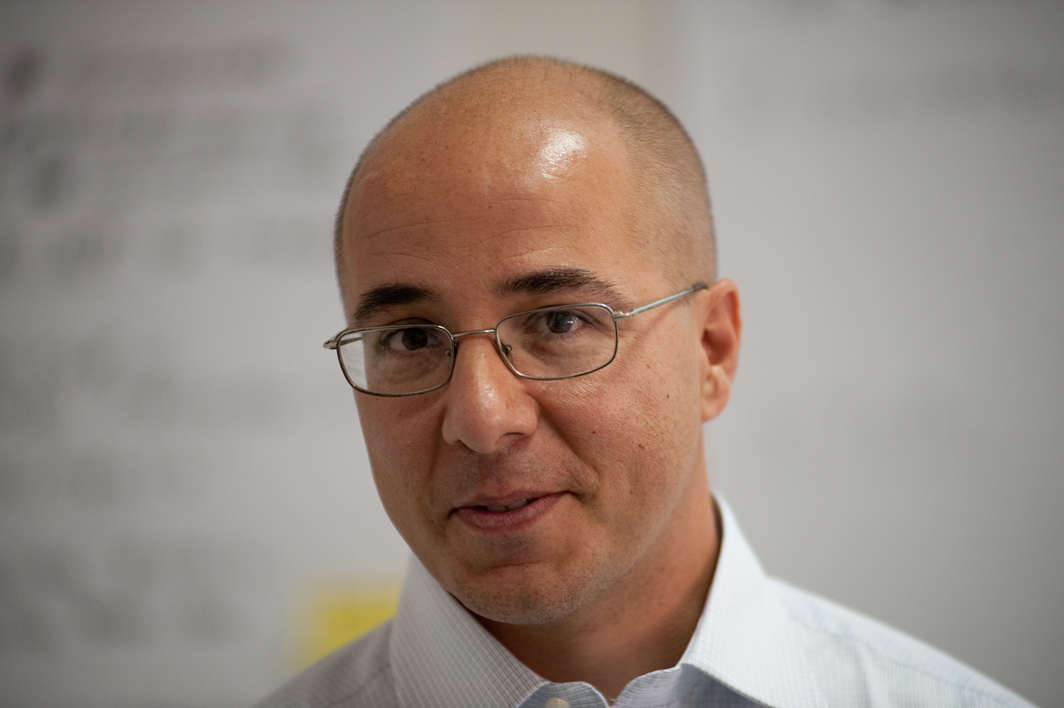Piacenza ha reso omaggio alle vittime della Shoah

Anche Piacenza ha reso omaggio alle vittime della Shoah nella Giornata della Memoria; la cerimonia istituzionale nel 77° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz si è svolta nel Giardino della Memoria in Stradone Farnese 6.
Al saluto del Prefetto Daniela Lupo è seguito l'intervento del Sindaco e Presidente della Provincia Patrizia Barbieri, mentre a don Giuseppe Basini, parroco della basilica di Sant'Antonino, è stato affidato il consueto momento di preghiera.
Il discorso del sindaco Patrizia Barbieri
“Immaginatelo così, cio che è stato. Tre generazioni della vostra famiglia hanno vissuto insieme nella stessa città, nella stessa casa. I vostri genitori hanno dato tutto per crescere i figli, hanno costruito amicizie e relazioni sociali. All'improvviso gli viene ordinato di lasciare ogni cosa entro l'indomani, portando con sé una sola valigia”. Con queste parole Irene Fogel Weiss, nata negli anni '30 nell'allora Cecoslovacchia, ritornando ad Auschwitz per condividere la sua testimonianza di sopravvissuta, raccontava: “Non dimenticherò mai quell'ultima notte con la valigia sul letto. La riempimmo di cibo, di vestiti caldi, di lenzuola. Un orologio, un paio di orecchini e una fede nuziale come merce di scambio, ma in realtà non avevamo alcuna consapevolezza dell'inferno che ci attendeva”.
Mentre il treno si arrestava su quei binari che la storia ci ha consegnato, per sempre, come simbolo dell'ideologia nazista dello sterminio di massa, il suo papà intravvide i prigionieri in uniforme e le baracche: “Pensammo che, se ci avevano mandato qui per lavorare, la vita sarebbe potuta andare avanti. Ci aggrappammo alla speranza che avremmo potuto riabbracciarci ogni sera, dopo una giornata di fatica. Era quello, del resto, l'ingranaggio chiave della soluzione finale: l'inganno. La consapevolezza che le persone avrebbero fatto affidamento sulla propria normale percezione delle cose, fino alle estreme conseguenze: credere di essere mandati a fare una doccia, mentre ci si incamminava verso la camera a gas”.
Fu quello che accadde alla sua mamma, alla sorellina. Ma Irene – che si salvò perché sembrava più grande della sua età – lo avrebbe scoperto solo molti anni dopo, riconoscendole in una foto dell'epoca, mano nella mano in fila tra centinaia di donne, ragazze e bambine come loro, smistate lungo la cosiddetta “Judenrampe” come si fa con gli oggetti senza più utilità. Sul loro destino cadeva lo sguardo impietoso di ufficiali e medici delle SS: per i più piccoli, per le madri in attesa, per gli anziani e i disabili, così come per coloro che apparivano malati, la condanna era immediata, appena scesi dal vagone. Senza neppure procedere all'identificazione.
Era l'atrocità di un'efficienza perseguita e sperimentata scientificamente, che tra il 1943 e il 1944, quando le deportazioni raggiunsero il picco massimo, faceva nel solo campo di Auschwitz, rinchiuse tra le esalazioni dello Zyklon-B, 6000 vittime ogni giorno. Oltre 4000 – ma gli addetti sostengono che si arrivasse persino al doppio – i corpi esanimi bruciati quotidianamente nei crematori di Birkenau, dopo che altri detenuti, addetti a questa macabra, barbara procedura, ne avevano rimosso la dentatura d'oro e i capelli, perché il Reich potesse trarre profitto da quelle vite cui era stata tolta, prima ancora di ciò che aveva un valore economico, ogni forma di dignità e rispetto.
Educare i giovani a rifiutare ogni forma di razzismo
“Fino all'ultimo hanno tentato di eliminare tutte le persone possibili”, ricorda la scrittrice Edith Bruck, giunta ad Auschwitz non ancora 13enne, poi trasferita in altri lager sino a Bergen Belsen, dopo un'estenuante marcia della morte: “Era la fine della fine, anch'io ero ormai una specie di nullità: pesavo 20 chili. Ma i tedeschi non volevano lasciare testimoni e non dovevamo esistere nemmeno noi, né per loro né per quei pochi parenti sopravvissuti... C'erano macerie ovunque, eravamo macerie anche noi che siamo tornati. Pensavamo che un giorno il mondo si sarebbe inginocchiato davanti a noi per chiedere perdono per ciò che è stato fatto a degli innocenti. Invece non fu così... l'Europa era distrutta, c'era la fame... e noi eravamo una specie di avanzo”. Nonostante tutto, non ha mai dimenticato la promessa che fece, adolescente, ai compagni di prigionia che morivano intorno a lei: “Non ci crederanno, ma tu racconta. Se sopravvivi, racconta anche per noi”.
Perché è questo, il Giorno della Memoria: dare voce a chi può ancora testimoniare quell'orrore e ascoltarne le parole, custodirle, difenderle come un'eredita morale da cui le nostre scelte e il nostro impegno civile non possano mai più prescindere. Educando le giovani generazioni a rifiutare e contrastare il razzismo e la discriminazione, la sopraffazione dei forti sugli inermi, l'indifferenza di fronte alle richieste di aiuto e alla sofferenza del prossimo.
Nel 77° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, il nostro pensiero commosso e partecipe va allora ai milioni di donne, uomini, bambini e ragazzi che non hanno mai fatto ritorno dai campi di concentramento e sterminio, perché la loro religione, la loro appartenenza etnica, le loro idee politiche, il loro orientamento sessuale o il loro aspetto fisico non erano conformi alle aberrazioni dell'egemonia ariana. Alle centinaia di migliaia di vite violate e calpestate con brutalità feroce nei ghetti delle grandi città europee. A tutti coloro che subirono umiliazioni e torture indicibili, nel nome dell'odio antisemita e della persecuzione dei diversi.
Perché la volontà e il dovere di coltivare la memoria, di onorarne il significato e i tragici insegnamenti, sono essenziali nel far sì che nessuno, come ha scritto Primo Levi, debba più subire “l'esperienza non umana di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo”.
Quattro medaglie alla memoria
In questa giornata di ricordo e riflessione comune, il prefetto Daniela Lupo, nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, nel Salone delle Armi della Prefettura, ha provveduto alla consegna delle medaglie d’onore che ai sensi dalla legge 296/2006 vengono concesse ai cittadini italiani, militari e civili, ovvero ai familiari dei deceduti, che siano stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Nella nostra provincia quattro sono le medaglie che sono state consegnate alla memoria:
CLAUDIO FAIMALI (alla memoria) militare deportato dal 10/09/1943 al 25/05/1945 e internato A Witemberge – M.Stammlager III A Arb. KD.575;
RIZIERO LATRONICO (alla memoria) militare deportato dal 18/11/1943 al 06/09/1945 e internato in Germania.
LUIGI MERLINI (alla memoria) militare deportato dal 09/09/1943 al 25/04/1945 e internato a Forbach 12 F;
ALESSANDRO REPETTI (alla memoria) militare deportato dal 14/09/1943 al 15/05/1945 e internato in Germania.


Nelle foto di Carlo Pagani, i momenti della Giornata della Memoria a Piacenza.
Pubblicato il 27 gennaio 2022
Ascolta l'audio