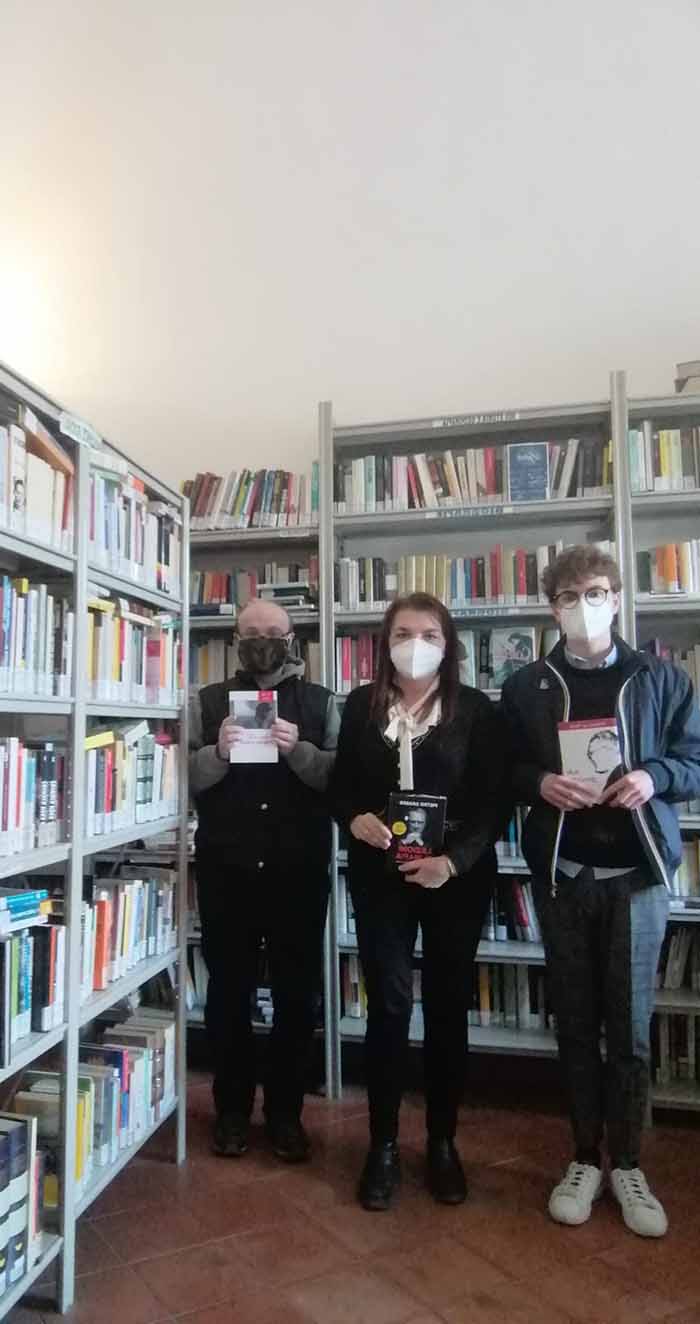Sarà trasmesso in prima serata sabato 27 marzo, su un circuito di emittenti locali e a diffusione regionale in tutta Italia, il concerto che Daniele Ronda ha tenuto il 17 febbraio scorso in piazza Cavalli, a Piacenza.
“Una serata che – sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – diffusa in live streaming su Facebook, aveva registrato successo ed entusiasmo, evidenziando quel desiderio di condivisione e unità di cui la musica sa farsi interprete e portatrice in modo universale. E’ motivo di grande orgoglio, sapere che questo messaggio di speranza e di solidarietà verso tutti i lavoratori dello spettacolo, partito dalla nostra città, potrà essere ora veicolato in tutto il Paese, unendo l’arte di un cantautore di talento alla suggestione del nostro patrimonio storico e architettonico”.
Andrà quindi in scena, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tutte le emittenti aderenti all’iniziativa, la performance di 90 minuti che alla musica intreccia l’esibizione di danzatrici, ginnaste e artisti circensi, in un intreccio di emozioni con i duetti tra piano e voce con la cantante Francesca Mazzuccato, la presenza del violoncellista Massimo Bertucci a simboleggiare il settore della musica classica, l’interpretazione dell’attrice Marina De Juli in un brano che affronta il dramma della violenza contro le donne.
Daniele Ronda, accompagnato dalla sua band al completo, ha affidato alle sue canzoni l’auspicio che tutte le città possano al più presto animarsi di musica live, allestimenti teatrali, forme d’arte e creatività che la pandemia ha costretto a fermarsi o limitato in questi mesi alla fruizione indiretta, online. Evocativo, a questo proposito, il titolo della sua ultima uscita musicale: “Prima o poi”.
“Il concerto del 17 febbraio scorso, realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza – aggiunge l’assessore Papamarenghi – è stato occasione per ripercorrere, tra note folk e che invitano a ballare, altre più malinconiche e intimiste, il dolore e la solitudine di questo anno così difficile, invitando però a guardare al futuro nel segno della coesione e del trasporto che la cultura, la musica e l’arte riescono sempre a darci. Ringrazio Daniele, per questo, unitamente a tutte le emittenti che hanno voluto contribuire a diffondere questo segnale”.
Pubblicato il 25 marzo 2021